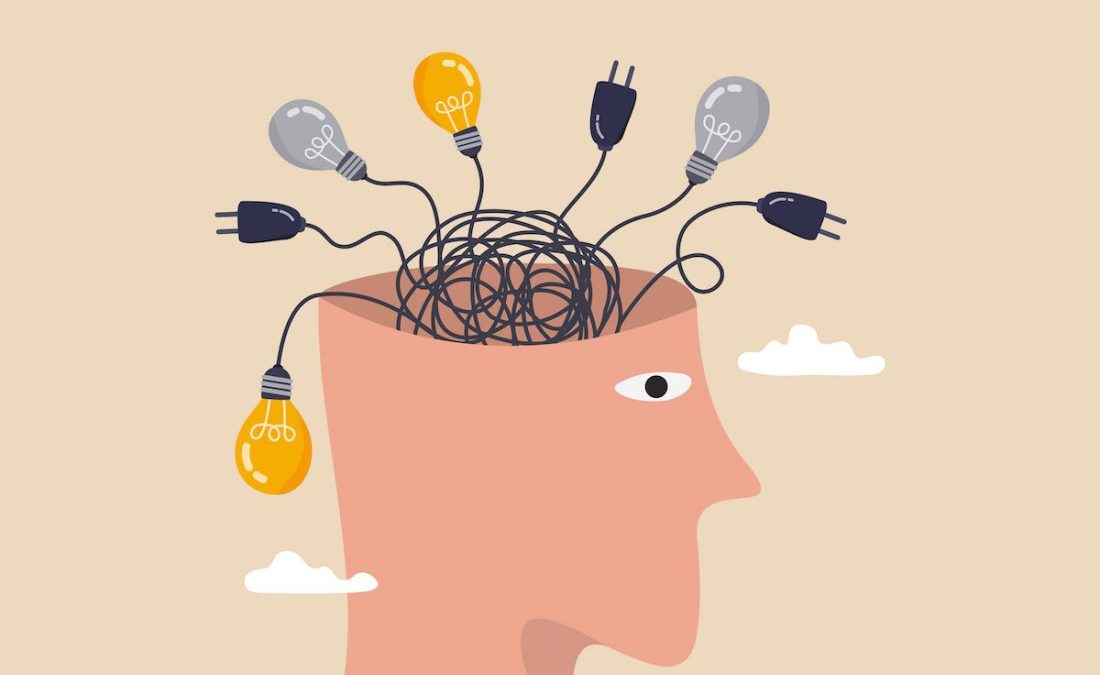Il rimuginio è un processo mentale caratterizzato da un catena di pensieri negativi relativamente incontrollabili. Esso è fortemente correlato con i disturbi d’ansia, e in particolare con il disturbo d’ansia generalizzato, e costituisce un fattore di mantenimento per l’ansia stessa, attraverso i suoi correlati psicosomatici e cognitivi. Sotto un certo punto di vista, il rimuginio è facilitato da stati di eccessiva vigilanza, di attenzione selettiva verso gli stimoli sia esterni che interni (percettivi ed emozionali) minacciosi, di maggiore presenza nella memoria a lungo termine di informazioni negative e/o minacciose (Mathews, 1990). Tuttavia, è difficile stabilire se questi fenomeni siano effettivamente degli antecedenti del rimuginio, o semplicemente accompagnino l’insorgere del rimuginio e ne siano quindi semplicemente un aspetto.
MacLeod e Mathews (1988) hanno mostrato che la vigilanza intensa è una caratteristica tipica dei soggetti ansiosi e rimuginatori anche quando il loro stato mentale non sia ansioso. Questo risultato pesa a favore dell’ipotesi dell’ipervigilanza come antecedente.
Il rimuginio però è stimolato non solo dagli stati mentali che lo precedono, ma anche dagli scopi positivi ad esso consapevolmente attribuiti dal soggetto rimuginatore stesso (Borkovec et al., 1998). In altre parole, il soggetto tenderebbe ad attribuire al rimuginare delle funzioni positive, degli scopi vantaggiosi, ed in tal modo rafforzerebbe il rimuginio e spiegherebbe a se stesso la sua tendenza a rimuginare. Il primo scopo positivo attribuito al rimuginio è l’attenuazione di uno stato d’animo immediatamente sgradevole, e cioè l’ansia somatica, l’arousal neuropsichico delle emozioni negative. Borkovec et al. (1993) sono riusciti a mostrare una correlazione tra l’ammontare di pensiero verbale astratto e il grado di soppressione fisiologica. Anche le immagini evocate nel rimuginio sono comunque meno vivide e concrete di quelle che si generano nell’attività mentale non rimuginativa (Borkovec e Inz, 1990; Stöber, 1997). Anche altri studi hanno mostrato questa correlazione tra attività rimuginativa e controllo e raffreddamento degli aspetti cardiovascolari e somatici dell’ansia (Mathews, 1990; Parkinson e Rachman, 1981; Smith, 1984; Gray, 1982)
In secondo luogo, il rimuginio può essere scambiato per una strategia efficace di soluzione dei problemi. Infatti il rimuginio è comunque una attività mentale, sia pure povera e ripetitiva, e come tale può essere confusa con il pensiero produttivo. Molti ansiosi, quando rimuginano, ritengono di stare affrontando il problema. In realtà si tratta di una strategia fallace e vuota. Secondo Eysenck (1992), nel rimuginio ad una fase di “alarm”, in cui la minaccia è avvertita, ed ad una fase di “prompt” in cui essa è individuata e definita, succederebbe una fase di elaborazione di piani di gestione del pericolo (“internal task models”). Tuttavia, affinché la terza fase sia efficace, sarebbe necessario che il soggetto preoccupato cessi almeno parzialmente di rimuginare, poiché un buon grado di concretezza nella elaborazione mentale delle informazioni è cruciale nella formulazione di piani efficaci (Schöpflung, 1989). Nel rimuginio patologico, mancando questo aspetto, si determinerebbe proprio la mancata elaborazione di piani efficaci. Di conseguenza, la minaccia non sparisce, ed il rimuginio permane, riducendo il pensiero alla funzione di soppressione dell’ansia. Tuttavia, nel soggetto permarrebbe la sensazione, fallace ed errata, di pensare e quindi di risolvere e di affrontare il problema.
In terzo luogo, il rimuginio può essere ritenuto una strategia di distrazione da preoccupazioni ancora peggiori. I soggetti rimuginatori mostrano una rete di associazioni di eventi previsti negativi molto più ricca dei non rimuginatori (Vasey e Borkovec, 1992). Essi “vedono” molti più possibili guai e disgrazie nell’ambiente circostante dei non rimuginatori e inoltre prevedono strati successivi di guai e catastrofi gerarchicamente ordinate. In altre parole, ad esempio dietro il timore di avere incertezze durante una prestazione sociale si celano i timori ben più catastrofici di fallire l’intera prestazione, di essere considerato socialmente incapace in generale, di subire emarginazione o ostracismo sociale, di subire danni materiali (ad esempio mancate promozioni lavorative, mancati avanzamenti di stipendio, essere accantonati in posti di scarsa soddisfazione o responsabilità o addirittura perdita del posto di lavoro) e affettivi (perdita della stima del partner, crisi del rapporto, fine del rapporto, ecc.)